La gaia educazione
La gaia educazione
Su una raccolta di scritti di Fernand Deligny
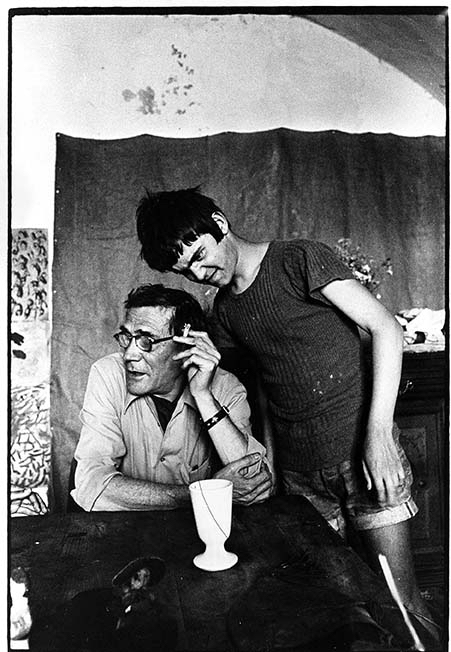
Di Alessandro Siciliano, dapprima pubblicato su Dinamopress
La vicenda di Fernand Deligny si svolge tra gli anni Quaranta e i Sessanta del secolo scorso. Prima in manicomio, poi in istituzioni inventate ad hoc per ragazzi e ragazze fuori norma, infine ai margini estremi rispetto a società e istituzioni, sui monti delle Cévennes, nella Francia meridionale, con ragazzini definiti autistici. Si tratta di una vicenda che si svolge in un tempo in cui si va definendo sempre più e sempre meglio, fino al culmine del Sessantotto, la contestazione dell’ordine simbolico vigente, troppo asfissiante, troppo esigente. Ed è una vicenda pienamente figlia del suo tempo.
Ordine simbolico, va ricordato, significa tra le altre cose ordine reale, significa modi di vita determinati, norme determinate, funzioni determinate, sensi determinati. Chi dice “ordine simbolico” dice “è così che va il mondo”. E ogni “così” traccia, nello stesso gesto, un dentro e un fuori.
Sarà dunque, nello specifico, la critica e la decostruzione delle istituzioni dedicate al trattamento di chi è “fuori”, a fare l’atmosfera culturale e intellettuale in cui fiorisce la vicenda di Deligny, in cui avviene l’incontro di quest’uomo con il problema che lo interesserà per tutta la vita: il problema dell’educazione. Non l’educazione in sé, ma qualcosa di molto più ostico: l’educazione degli ineducabili, dei folli, delle canaglie, l’educazione di chi ha poco o niente da spartire con la posta in gioco in ciò che chiamiamo “educazione”.
Deligny incontra centinaia, migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze alle prese con varie forme di conflitto con l’ordine simbolico. Uso questa espressione del tutto generica perché ci troviamo al di qua della “diagnosi”, intesa come tempo della comprensione di un problema, al di qua della possibilità di comprendere qualcosa dello specifico di ciò che riguarda quella sofferenza lì, quel disagio lì. Si tratta, “molto semplicemente”, di piccoli d’uomo destinati al manicomio o al carcere, per scostamenti intollerabili rispetto alle norme. Adolescenti identificati al proprio comportamento, al proprio agito fuori legge. Il tale comportamento, il tale agito, ripetuti, disegnano automaticamente l’orizzonte del carcere o del manicomio. Contro queste due grandi destinazioni, Deligny inventa territori intermedi, opera per deviazioni delle rotte che dal tale comportamento portano dritte verso la tale “istituzione totale”.
La questione di Deligny fu, in questo senso, la stessa che incontrò anche Franco Basaglia. Anche Basaglia incontra e abita l’istituzione totale, anche lui ne patisce gli effetti. Soprattutto, anche Basaglia come Deligny si trova collocato nel medesimo “al di qua” che dicevamo, nella stessa posizione preliminare. Prima di ogni diagnosi, prima di ogni tecnica, ci si chiedeva, come possiamo noi operare diagnosi, tecnica o metodo accettando sic et simpliciter le condizioni di partenza dell’istituzione totale, della società che pensa e produce simili istituzioni, della scienza otturata dall’ideologia del produttivismo e della segregazione degli improduttivi? Non dobbiamo forse mettere tra parentesi, fare epochè della nostra scienza e della nostra tecnica, per ricavare in primis una rinegoziazione dello spazio, simbolico e reale, dedicato agli scarti della società? Non dobbiamo forse, per far ciò, rifiutare la logica del rifiuto? Quale scienza e quale tecnica sono possibili, se la macchina è già preimpostata per dare sempre lo stesso risultato?
Deligny è educatore. Educare viene dal latino educere, composto da e (da, di, fuori) e ducere (condurre, trarre): portar fuori, trarre fuori. Tutto il problema sta già qui nell’etimo, e le pagine de I vagabondi efficaci lo restituiscono piuttosto fedelmente. Si direbbe che, più che argomentare pro o contro, l’autore di questi scritti si lasci parlare dalla complessità di quel problema, dalle contraddizioni, le ambiguità e le tortuosità che esso porta con sé. Non è tuttavia un lasciarsi parlare passivo, ma a partire da una posizione ben precisa: mentre guarda i suoi ragazzi e ragazze, l’educatore si guarda allo specchio e presta attenzione a quel duce che troviamo nel verbo ducere. È uno sguardo rivolto all’interno, se non un’autoanalisi, certamente un’autocritica.
Credo sia utile chiamare in causa questo termine dalle risonanze storiche tanto imbarazzanti. Il duce è il condottiero, colui che ha il compito di condurre il transito educativo dal caotico e capriccioso dentro all’ordinato e ideale fuori. Gli interrogativi sorgono spontanei: chi è il duce? Come e perché opera, cosa lo causa, cosa lo muove? È mero paradigma dell’uomo del suo tempo? E verso dove conduce quella materia che è non-ancora-uomo?
Si nota immediatamente che la messa in discussione della funzione dell’educatore coincide con la messa in discussione dell’ordine simbolico e della società di cui l’educatore è espressione diretta. L’ispirazione rivoluzionaria di Deligny consiste allora nell’interruzione della logica che farebbe del duce e degli allievi i termini di una relazione già scritta, e nell’infaticabile questionamento di ciò che è possibile o non è possibile fare nello spazio di questo non-rapporto.
Il questionamento del ruolo e della funzione dell’educatore rispetto agli allievi va di pari passo con il questionamento della società e del senso di una vita. Il senso della vita e il senso di una vita, nello spazio della relazione educativa, si incontrano e si scontrano, dibattono, si annodano e si snodano, e Deligny si fa fedele testimone di questo conflitto.
Ma il problema di Deligny, dicevamo, si spinge ancor più in là. L’incontro con ragazzini fuori-norma rende la figura del duce, insita nel compito educativo, più caricaturale e più impotente di quanto non possa essere già per sua stessa natura. Qui abbiamo la domanda fondamentale che morde l’educatore di ineducabili: come e dove condurre chi, anziché tenere il passo del maître, vaga? Come e dove instradare chi sta semplicemente passeggiando inutilmente? Come fare con la stortura, con la devianza?
Inutilità del vagabondaggio. È facile notare negli scritti di Deligny più che un rispetto, quasi un amore per queste erranze. Un amore di cui lo stesso Deligny teme di inebriarsi narcisisticamente, e così si richiama più volte su un punto: «non si tratta di amarli, ma di aiutarli», si legge spesso in queste pagine. Aiutarli a rendersi, secondo la felice espressione che i curatori pongono giustamente come titolo di questa raccolta di scritti, vagabondi efficaci.
Il vagabondo efficace, per Deligny, è colui che, nel mentre persevera nella sua linea di erranza rispetto al discorso corrente, nel mentre vaga anziché marciare ordinato assieme agli altri, trova un modo singolare per non consegnare la sua erranza alla morte, per fare con la propria erranza uno stile e un modo di vita, nonostante tutto.
Al cuore di una postura come questa c’è una scommessa, una supposizione: che ci sia in quella stortura, o accanto a quella stortura, un progetto, che non punta necessariamente alla morte, un programma che vale la pena studiare e seguire, prestando tutti gli strumenti utili a compiere un viaggio in sicurezza, argini, sponde, corde, nodi. Aiuti, appunto. Aiuti per l’attuazione di un progetto inconscio sia al ragazzo sia all’educatore, aiuti contro la deriva puramente dissipativa.
Dal punto di vista dell’ideale formativo, che è quello del duce nella sua forma pienamente compiuta, il sintomo o problema è ciò che occorre risolvere e piegare. Ma cosa diventa il sintomo o il problema dal punto di vista del soggetto che li produce?
Questa, in fondo, la domanda che Deligny si pone nel corso della sua vicenda, che fa la sua vicenda. Una domanda che porta totalmente fuori dalla comfort zone della didattica, del programma e della relazione educativa stabilite dall’istituzione. Occorre soffermarsi attentamente sulla quota di rischio che una domanda del genere porta con sé, il rischio di una sorta di idillio della differenza, di una stabilizzazione identitaria del “diverso”, di ciò che Jacques Lacan definì una volta «supremo narcisismo della causa persa». Il rischio, insomma, di sposare un fare che sarebbe per sua natura fuori-istituzione – e che dunque si collocherebbe precisamente nel posto che l’istituzione umana stessa riserva al “fuori”.
Questo rischio rende i suoi scritti certamente più accattivanti. Tuttavia Deligny, lo dicevamo, si dedica a suo modo alla rinegoziazione dei luoghi simbolici e reali in cui si tratta il “fuori”. E se pure tale intento sembra sbiadire man mano che ci si avvicina all’ultimo periodo della sua vicenda, in cui alcuni hanno visto una sorta di poetica dell’autismo, spetta in ogni caso al “lettore impegnato” usare questi scritti in chiave innanzitutto politica, a seconda della propria implicazione in un problema, mettendoci del proprio.
Sta dunque qui la cifra politica dell’operazione di Deligny, che noi possiamo recuperare oggi e declinare al presente. Vale la pena rileggere queste pagine, che richiamano l’attenzione del lettore a quella impossibilità che Freud individuò al cuore del lavoro educativo. Un lavoro è impossibile quando non c’è scritto da nessuna parte “come fare”.
Freud ne annoverava tre: psicoanalizzare, educare, governare. Tre posizioni “insostenibili”, che espongono colui che vi si colloca a una moltitudine di rischi e difficoltà, per via della dissonanza tra ciò che c’è di propriamente impossibile nell’operazione e tutto ciò che di possibile ci si può inventare per avere a che fare con l’operazione, che nondimeno resterà impossibile, per un verso sempre votata al fallimento. Deligny ci invita a tenere in considerazione le virtù, potremmo dire, della dimensione fallimentare del compito educativo, perché ogni volta che qualcosa fallisce, mentre qualcosa fallisce, qualcos’altro sta trionfando da qualche altra parte. Compito di una gaia educazione sarà cercare ciò che, nel fallimento, sta funzionando efficacemente.





